Il gioco in Platone (terza parte).
Il gioco in Platone assume se non una vera e propria sfumatura teologica, quantomeno un’aura sacrale. Infatti in un passo della sua opera possiamo leggere:
«ATENIESE – Io dico che
noi dobbiamo occuparci di ciò che ha valore e tralasciare il resto; la divinità
è per natura degna di interesse, che sia anche fonte di beatitudine, ma l’uomo,
lo abbiamo detto prima non è che un giocattolo uscito dalle mani degli dei e
ciò che di lui vale di più è proprio questo, in realtà. E in modo a ciò conseguente
ogni uomo e ogni donna devono vivere anche la loro vita, cioè giocando i giochi
migliori» [1].
E poco dopo lo Stagirita aggiunge:
«E quale sarà il retto
modo di vivere? Sarà quello di fare il proprio gioco, sacrificando, cantando e
danzando, per vedere se con ciò si riesca a rendere propizi gli dei e a tenere
lontano i nemici, sconfiggendoli in guerra» [2].
Questi passi, non correttamente intesi,
possono essere assunti come punto di partenza per una visione nichilistica,
come in epoca contemporanea è stato fatto.
Nietzsche – che era, per formazione, un
filologo! – vede in queste affermazioni di Platone, che tanto denigra e critica,
la più chiara attestazione del fatto che l’uomo sia una “marionetta” nella mani
di Dio e, dunque, sia esposto alla casualità più totale [3].
In realtà questo pre-giudizio, che ha fatto scuola in tantissima letteratura
contemporanea [4],
è facilmente superabile alla luce del contesto in cui i sopracitati passi si
collocano. Infatti nel VII libro delle
Leggi, opera che non è disgiungibile dalla Repubblica in quanto «essi descrivono lo stato secondo, ossia
quello che viene dopo quanto rappresentato come una favola nella Repubblica» [5],
si parla dell’educazione, della paideia.
Data l’evidente prossimità etimologica, nel greco classico, tra paidea e paidia, si può affermare a ragione che, nei passi citati, Platone
sottolinei la tonalità ludica della condizione umana. Il filosofo ateniese
intuisce, senza sviluppare, dato che siamo in presenza di un hapax in tutta l’opera platonica, la
parentela tra l’esistenza umana e il gioco. In altri termini la vita dell’uomo
è un gioco che si sostanzia in sacrifici, canti e danze, in giochi consacrati
alla divinità che, expressis verbis,
sono l’obiettivo più alto cui l’uomo possa dedicare la sua energia [6].
La metafora che Platone utilizza ha, pertanto, un indubbio valore antropologico.
Tuttavia in che senso l’uomo, che pure gioca, è giocattolo del dio? Il rischio di
degradare il gioco a figura dell’effimero e dell’assurdo è forte. Ma il giocattolo
non indica alcunché di insignificante, anzi sta a indicare qualcosa di
prezioso, di caro. Infatti
«è significativo notare
che, mentre i bambini selezioni giochi e giocattoli, per il bambino – specie
molto piccolo – tutto è gioco e tutte le cose, perfino le più insignificanti e
noiose, sono giocattoli a portata di mano; ogni cosa lo occupa, impegna,
vincola e gli promette» [7].
Pertanto, attraverso il gioco, Platone
indica tanto la condizione umana quanto la condizione del divino. Il dio è un deus ludens, un dio che gioca. Il gioco
è anche il tratto caratteristico del divino, non solo dell’umano.
«Che l’uomo sia un
giocattolo comporta certo la consapevolezza di non poter padroneggiare la
propria origine rispetto al divino e, Platone, in tal senso usa la metafora.
Quest’ultima, però lascia intravedere anche altri significati; non solo che per
l’uomo giocare è un fatto d’autenticità, ma anche gli dei giocano.
Indubbiamente è sempre una delicata questione quella del rapporto tra il
giocare umano e quello divino: il timore che quest’ultimo sia il nostro essere
giocati è legittimo. Ma se il gioco umano, platonicamente, è imitativo, quello
divino non può che essere creativo o ri-creativo e, dunque, partecipazione o
reintegrazione del bene» [8].
[1] Platone, Leggi, VII, 803 d.
[2] Ibi, 803 e.
[3] Per un’efficace e puntuale ricostruzione dell’approssimativo giudizio di
Nietzsche sul gioco in Platone, cfr. E
Fink, La metafisica nietzschiana del gioco, in
Idem, Per gioco, 25-44.
[4] La posizione nichilista è stata assunta, senza critica, dal cosiddetto
pensiero debole di cui, in Italia, i massimi interpreti sono Rovatti e Vattimo.
Cfr P.A. Rovatti – A. Lago, Per gioco: piccolo manuale dell’esperienza
ludica, Raffaello Cortina, Milano 1993. Sul problema della comprensione del
gioco in epoca contemporanea, cfr. G.
Mattai, Gioco, in Dizionario Teologico Interdisciplinare, II, Marietti, Genova
1997, 209-213.
[5] F. Giacchetta, Gioco e Trascendenza, 77. Sul legame tra
Leggi e Repubblica, cfr. G. Reale, Storia della filosofia antica, Vita e
Pensiero, Milano 1981, II, 339-34.
[6] Cfr. Platone, Leggi, VII, 804 a.
[7] G. C. Pagazzi, Fatte a mano, 43.
[8] F. Giacchetta, Gioco e trascendenza, 78-79.


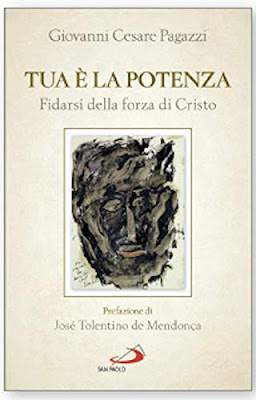

Commenti
Posta un commento