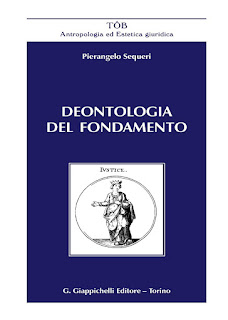Il gioco in Aristotele
Aristotele tratta del gioco nell’Etica Nicomachea. Anche se, come è noto,
la pubblicazione delle opere dello Stagirita è dovuta ai suoi discepoli, in quanto egli non
concepì mai le sue opere come libri da pubblicare ma come il sostrato dell’attività
didattica [1],
la collocazione della trattazione del gioco è di particolare interesse. Infatti
esso è fatto oggetto di indagine all’interno del IV libro, dove si parla delle
virtù etiche, delle virtù cioè legate al comportamento. Tra di esse vi è il
garbo che, a giudizio di Aristotele, trova la sua più evidente espressione nel
gioco. Pertanto giocare, o meglio saper giocare, è questione di comportamento, di virtù. Lo Stagirita così si
esprime:
«il riposo, poi, e il
divertimento (paidia) si ritiene che
siano necessari nella vita. Nella vita corrente, tre sono le medietà di cui
abbiamo parlato, e tutte e tre riguardano i rapporti reciproci fatti di parole
e azioni. Ma differiscono perché una riguarda la verità, le altre due il
piacere. Di quelle che riguardano il piacere, infine, una si manifesta nei
divertimenti (paidiai), l’altra nelle
compagnie che si costituiscono nelle altre occasioni della vita» [2].
Poco prima lo Stagirita aveva distinto
l’uomo garbato (eutrapelos) dal
buffone (bomolochos) che cerca l’allegria
ad ogni costo e dal burbero ingrugnito in una serietà ostinata (agroikos) dichiarando che
«alla disposizione di
mezzo appartiene il garbo: è proprio dell’uomo garbato dire e ascoltare sole
cose che si intonano al carattere di uomo virtuoso e libero. Ci sono, infatti
cose che un tale uomo può convenientemente dire o ascoltare a mo’ di scherzo (paidia), e lo scherzo (paidia) dell’uomo libero differisce da
quell’uomo servile, come pure lo scherzo (paidia)
dell’uomo ben educato differisce da quello di privo di educazione. Questa
differenza si può vedere anche dal confronto delle commedie antiche con le
moderne; per gli autori antichi era divertente la battuta oscena, per i moderni
piuttosto il sottointeso: e non è piccola la differenza tra questi due atteggiamenti
dal punto di vista del decoro […]. Per conseguenza l’uomo raffinato e libero
avrà questa disposizione, perché egli è legge a se stesso. Tale è dunque l’uomo
del giusto mezzo, uomo di garbo o uomo di spirito che dir si voglia. Il
buffone, invece, è schiavo del suo desiderio di far ridere, e non risparmia né
se stesso né gli altri pur di suscitare il riso e dice cose, nessuna delle
quali l’uomo raffinato direbbe; anzi, alcune di esse non le ascolterebbe
neppure. Il burbero, poi, è inadatto a tali compagnie: non vi contribuisce in
niente ed è sgradevole a tutti» [3].
Dunque, per Aristotele, senza
fraintendere il suo pensiero, giocare o meglio saper giocare è una questione
eminentemente di carattere etico e, nello specifico, una questione di virtù.
Nel II libro dell’Etica, all’inizio
di tutta la trattazione sulle virtù aveva affermato, infatti, in modo chiaro e
sintetico:
«riguardo al piacevole
nello scherzo (paidia) chi sta nel
mezzo si chiama spiritoso (eutrapelos)
e la sua disposizione (exis) spirito
(eutrapelia), l’eccesso si chiama
buffoneria (bomolochia) e chi la
pratica buffone (bomolochos), chi è
in difetto si dice rozzo (agrokos) e
la sua disposizione (exis) buffoneria
(agrokia)» [4].
Questa sua posizione ‒ il saper giocare
come una virtù ‒ viene ribadita nell’ultimo libro, il X, dove, sintetizzando
quanto affermato nei precedenti libri, viene detto che
«tali si ritiene
comunemente che siano le azioni conformi a virtù: compiere azioni belle e
virtuose, infatti è una delle cose che meritano di essere scelte per se stesse.
Lo sono anche i divertimenti piacevoli (paidia),
giacché gli uomini non li scelgono in vista di altre cose […]. Sono
apprezzabili e piacevoli le cose che sono tali per l’uomo di valore: per
ciascuno l’attività più degna di essere scelta è quella conforme alla
disposizione che gli è propria, e, per conseguenza, per l’uomo di valore è
quella conforme a virtù. La felicità, dunque, non sta nel divertimento (paidia): e, in effetti, sarebbe strano
che il fine dell’uomo fosse il divertimento (paidia), e che ci si affaticasse e si soffrisse per tutta la vita
allo scopo di divertirsi. Tutto noi scegliamo, per così dire, in vista di
altro, tranne che la felicità: questa, infatti, è fine in sé. Darsi da fare ed
affaticarsi per il divertimento (paidia)
è manifestamente stupido e infantile. Divertirsi, invece per potersi applicare
seriamente, come dice Anacarsi, sembra essere un atteggiamento corretto: in
effetti, il divertimento (paidia) è simile al riposo, giacché gli uomini
non potendo affaticarsi in continuazione, hanno bisogno di riposo». [5]
Concludendo l’Etica, Aristotele esalta, pertanto, il
gioco a motivo del suo carattere ricreante, riposante, che è quantomai necessario in un vita fatta di lavoro e fatica. Questo
spiega il motivo per cui saper giocare – questo sa fare l’eutrapelos, l’uomo
garbato - sia una virtù, in quanto l’uomo non può passare tutta la sua vita nel
divertimento, come vorrebbe il buffone, né può passare la propria esistenza
chiudendosi in un’eccessiva serietà, come invece farebbe il burbero.
(estratto dal mio libro Teologia del gioco, dove puoi trovare molto altro)
Vedi il post sul mio libro: https://iltuttonelframmento.blogspot.com/2021/07/teologia-del-gioco.html.
[1] Cfr. G. Reale, Il pensiero antico, Vita e Pensiero,
Milano 2001, 185. In particolare, per la comprensione dell’etica aristotelica,
cfr. ibi, 214-222.